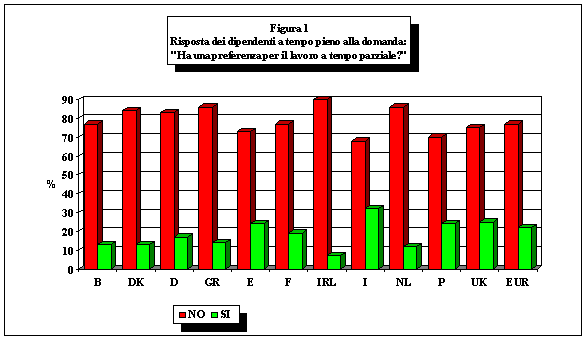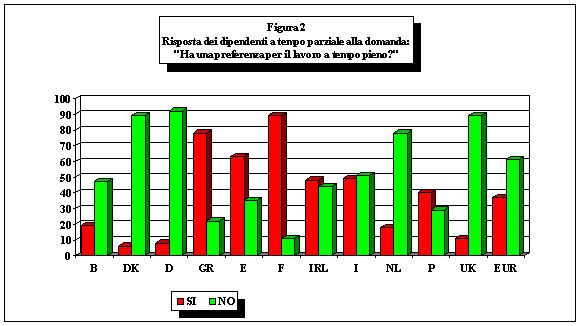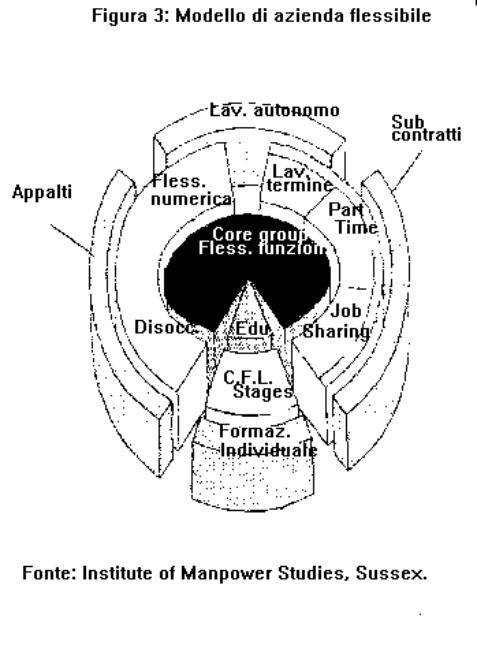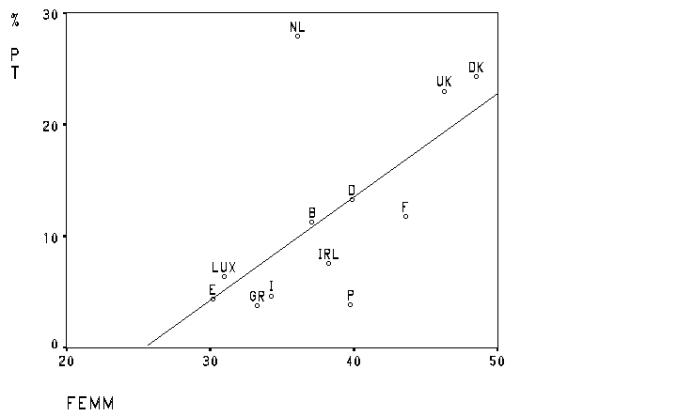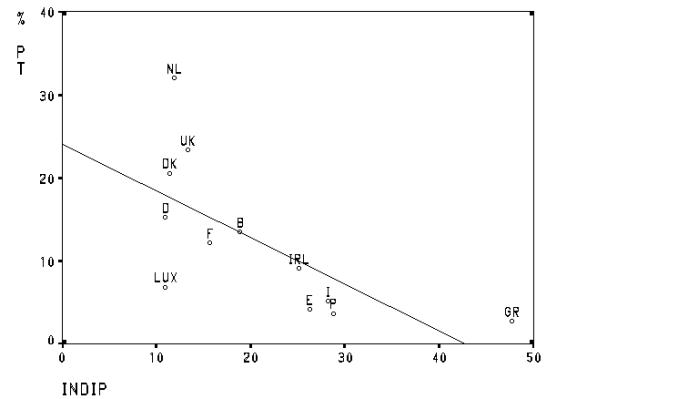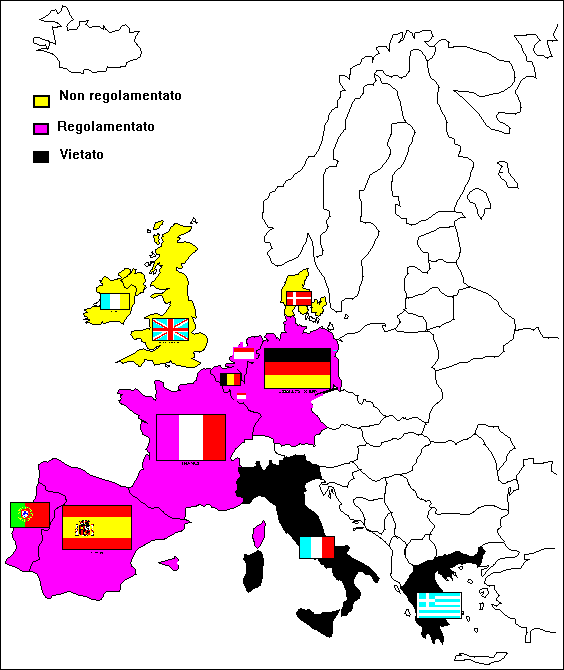Patrizio Di Nicola
Sociologo
QUALE FLESSIBILITA’ ? LAVORO ATIPICO E
PART-TIME IN ITALIA E IN EUROPA
(Marzo 1995)
Pubblicato su Economia e Lavoro
INDICE
1. Premessa
2. L'impresa flessibile
3. La flessibilità dei mercati del lavoro in Europa
4. Il caso italiano
5. Flessibili e interinali
6 Cenni conclusivi
QUALE FLESSIBILITA’ ? LAVORO ATIPICO E
PART-TIME IN ITALIA E IN EUROPA
1. PREMESSA
Una peculiarità delle società
moderne è rappresentato dallo sviluppo di attività che mettono in crisi il
modello di "lavoro subordinato standard". Costruzione questa che, seppur recente, aveva finito per identificarsi
nel lavoro tout court (L. Pero,
1990, A. Accornero, 1994). Molti dei
nuovi lavori, specialmente quelli terziari, sono "atipici" rispetto
a tale modello generale. Essi mancano, con varie articolazioni, di alcune caratteristiche che hanno connotato
il lavoro dipendente, quali la retribuzione legata alla disponibilità temporale del lavoratore
e la continuità ed esclusività della
prestazione. I fattori che hanno
contribuito, anche in Italia, allo sviluppo dei lavori atipici (Chiesi, 1990)
sembrano essere principalmente cinque:
a) richiesta di flessibilità da parte di chi offre il lavoro. Si tratta
di una tendenza spesso sottovalutata, ma che, specialmente negli anni più
recenti, ha assunto un discreto peso. Se guardiamo infatti i dati statistici
disponibili per l’Italia (tabella 1) notiamo che quasi un disoccupato su cinque
è alla ricerca di un lavoro che offra qualche forma di flessibilità oraria,
sia esso sotto la veste di lavoro autonomo ed auto-diretto che di impiego
dipendente a tempo parziale. Per specifici segmenti del mercato del lavoro
(ad esempio le donne disoccupate in condizioni non professionali, quali le
casalinghe) la quota di chi aspira ad un’attività “libera”,
almeno sotto il profilo della regolarità della prestazione e della sua adattabilità
alle proprie disponibilità individuali, supera il 33%.
Tabella 1: Tipo di occupazione preferita dai disoccupati.
Italia, 1992
(valori in migliaia)
Maschi
Femmine
|
|
Disoccupati
|
In cerca di
prima occupazione
|
Altre persone
in cerca di lavoro
|
Disoccu-pati
|
In cerca di
prima occupazione
|
Altre persone
in cerca di lavoro
|
Totale
|
|
Lavoro indipendente
|
2
|
2
|
106
|
1
|
1
|
84
|
197
|
|
Dipendente esclusivamente a tempo pieno
|
133
|
283
|
33
|
88
|
263
|
156
|
957
|
|
Dipendente esclusivamente a tempo parziale
|
8
|
19
|
9
|
15
|
26
|
77
|
154
|
|
Dipendente preferibilmente a tempo pieno
|
70
|
143
|
15
|
69
|
169
|
91
|
557
|
|
Dipendente preferibilmente a tempo parziale
|
9
|
21
|
9
|
23
|
35
|
86
|
183
|
|
Senza preferenze
|
75
|
224
|
64
|
58
|
184
|
146
|
751
|
|
Totale
|
297
|
692
|
238
|
254
|
678
|
640
|
2.799
|
Fonte: Istat, 1994b
b) riduzione del grado di tutela del lavoro dipendente (l'espansione
dei contratti di formazione e di quelli a tempo determinato ne sono un esempio)
();
c) la particolare modalità di "offerta" dei servizi, specialmente
di quelli privati destinati alle famiglie e alle imprese, che richiedono orari
lavorativi non standard;
d) l'importanza del fattore umano nel successo aziendale: si pensi
alle imprese di pubblicità, alle software houses, alle organizzazioni di "engineering".
Tutti lavori in cui conta più la creatività individuale che non la regolarità
della prestazione;
e) il fenomeno della plurioccupazione che, specialmente nei lavori
autonomi del terziario, rappresenta una buona quota dell'occupazione, come
si vede dalla tabella 2 che segue.
Soprattutto, comunque, ha pesato
la spinta alla flessibilizzazione che proveniva dalle aziende, sia prese singolarmente
(aumento dei contratti aziendali che prevedono forme atipiche di orario o
di prestazione - si pensi alle sperimentazioni di telelavoro in corso -) che
in forma associata.
Tabella 2: Lavori regolari e seconde
occupazioni nei servizi destinabili alla vendita. Italia, 1993.
|
|
Lavoratori regolari
|
Secondo lavoro
|
Rapporto percentuale
|
|
Unità di lavoro indipendenti
|
3.159.900
|
660.300
|
20,9
|
|
Posizioni lavorative indipendenti
|
3.159.900
|
1.650.700
|
52,2
|
Fonte: nostra elaborazione su Istat, 1994a
Lo sviluppo dei lavori atipici
non è solo e necessariamente l’espressione di una “forza positiva” che attraversa
il mercato del lavoro, come sostiene una certa retorica datoriale. La crescita
di attività non standard, infatti, è stato anche alimentato dall‘esistenza
di fasce di lavoratori strutturalmente "deboli" sul mercato. E’
il caso, come mostra la tabella 3, delle donne (che in percentuali sensibilmente
superiori agli uomini sono destinatarie di lavori part-time), ma anche degli
occupati a tempo determinato che, indipendentemente dal sesso, in oltre il
40% dei casi svolgono anche un lavoro di durata (e con retribuzione) ridotta.
E sommano, così, una doppia forma di flessibilità che, oggettivamente, può
in alcuni casi essere agevolmente definita come “precariato”. Questo spiega,
tra l’altro, l’ampio differenziale esistente tra il numero di lavoratori che,
svolgendo un’attività part-time vorrebbero averne una full-time e quelli che,
nella condizione opposta, aspirano invece ad un lavoro a tempo parziale (figure
1 e 2)()
Tabella 3 : Occupazione permanente, temporanea, a tempo
pieno e a tempo parziale. Italia, 1992
(Valori percentuali)
Agricoltura
Industria Servizi Totale
|
|
Permanenti
|
Tempo-ranei
|
Permanenti
|
Tempo-ranei
|
Permanenti
|
Tempo-ranei
|
Permanenti
|
Tempo-ranei
|
|
Maschi
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
Tempo pieno
|
96,6
|
50,1
|
99,3
|
70,0
|
98,7
|
64,4
|
98,8
|
62,8
|
|
Tempo parziale
|
3,4
|
49,9
|
0,7
|
30,0
|
1,3
|
35,6
|
1,2
|
37,2
|
|
N.
(x1.000)
|
966
|
139
|
5.019
|
195
|
7.391
|
235
|
13.376
|
569
|
|
Femmine
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
Tempo pieno
|
87,9
|
38,9
|
93,5
|
72,1
|
92,9
|
52,9
|
92,7
|
51,8
|
|
Tempo parziale
|
12,1
|
61,1
|
6,5
|
27,9
|
7,1
|
47,1
|
7,3
|
48,2
|
|
N
(x1.000).
|
486
|
158
|
1.556
|
81
|
4.878
|
355
|
6.920
|
594
|
Fonte: nostra elaborazione su
Istat, 1994b
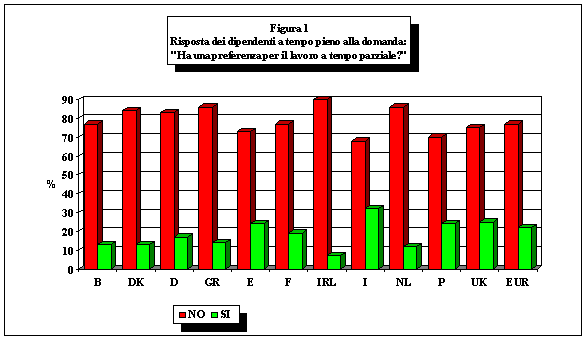
Fonte: Fondazione Europea, 1993
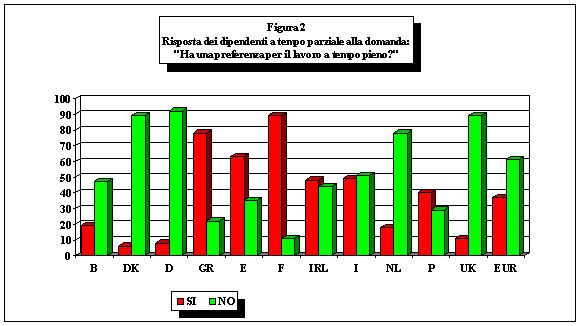
Fonte: Fondazione Europea, 1993
2. L'IMPRESA FLESSIBILE
Le imprese sono state particolarmente
rapide nell'utilizzare la perdita di rigidità del lavoro che ha caratterizzato
gli anni Ottanta, nonchè ad adattarsi alle nuove condizioni strutturali del
mercato del lavoro che anche loro avevano contribuito a costruire.
Si è così in breve tempo creato un mercato della domanda e dell'offerta
di lavori "non standard", impensabile soltanto un decennio prima. In questo contesto si afferma quella che è
stata definita dall'Institute of Manpower Studies impresa flessibile (J. Atkinson, 1986). Secondo tale analisi l'impresa moderna adatta e modifica il proprio
"output" (sia in termini di volume che, soprattutto, in termini
di coerenza con le richieste provenienti dall'utenza) sfruttando la flessibilità
interna del mercato del lavoro; il
modello organizzativo su cui essa è basata è riportato nella figura 3.
fig3
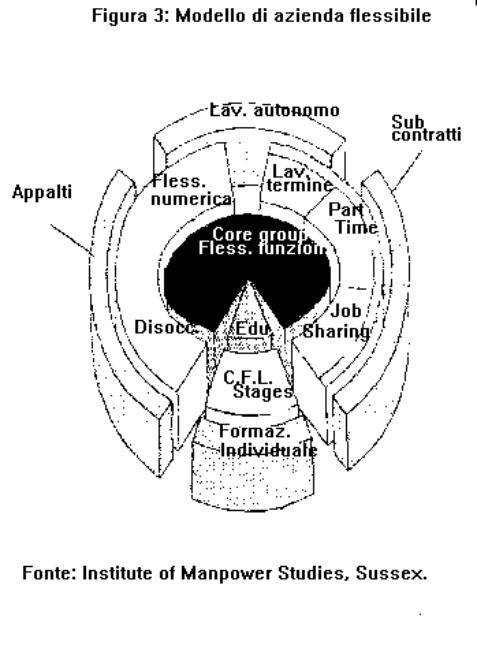
Alla base del costrutto teorico
vi è una distinzione basilare tra i diversi aspetti della flessibilità.
E' possibile infatti distinguere tra flessibilità
numerica, funzionale e di remunerazione. La prima consiste fondamentalmente nel "calibrare" la
quantità di occupati tenendo conto della situazione congiunturale della domanda.
I metodi per ottenere la flessibilità numerica sono molti, ma tutti basati
sull'uso di lavori atipici (a termine, part-time, ad interim, ad obiettivo).
L'impresa flessibile adotta quindi una organizzazione del lavoro che le permette
di adoperare estensivamente i lavori non standard allo scopo di mantenere
sempre il giusto numero di dipendenti, qualsiasi siano le fluttuazioni della domanda.
La flessibilità funzionale, al
contrario di quella numerica, si basa sulla adattabilità dei lavoratori per
far fronte a modifiche qualitative delle richieste di mercato, oppure indotte
dalla tecnologia o da cambiamenti nelle strategie aziendali. Tale forma di
flessibilità dipende strettamente dalle abilità e dalla volontà cooperativa
dei lavoratori (involvment, commitment).
Il terzo aspetto della flessibilità, quello legato alle retribuzioni, può
essere considerato "di supporto" ai primi due, in quanto in grado
di differenziare tra di loro i lavoratori sulla base delle prestazioni individuali
anzichè della qualifica. ()
L'impresa flessibile, secondo
tale modello, è costituita da un nucleo
centrale ("core group") di lavoratori garantiti e tutelati che assicurano
la flessibilità funzionale. Per Atkinson (1986, pag. 14) essi sono generalmente
maschi, lavorano a tempo pieno con un contratto di durata illimitata, sono
portatori di professionalità considerate strategiche per l'azienda e non risultano
immediatamente sostituibili in caso di defezione. Attorno al nucleo centrale si snodano due anelli
di forza lavoro definiti periferici
ed esterni. Il primo anello, che
ha il compito di assicurare la flessibilità numerica, è costituito da dipendenti
che svolgono lavori di routine, non critici dal punto di vista aziendale e
quindi facilmente rimpiazzabili. L'aggiustamento
alle condizioni di mercato è assicurato all'azienda dal rapporto di lavoro
di cui essi sono detentori: part-time, contratti a termine, job sharing, interim.
Non a caso è costituito principalmente da lavoratori giovani e da donne.
Il gruppo più esterno è anche il più eterogeneo: in esso possiamo trovare,
ai due estremi, sia addetti alla pulizia che consulenti di altissimo livello.
La caratteristica del gruppo è di essere detentori di abilità (o disabilità)
professionali che l'azienda non intende possedere al proprio interno, ma di cui non può fare a meno. A secondo della tipologia del lavoro
svolto (nonchè delle condizioni del mercato) gli "esterni" possono
essere utilizzati per incrementare la flessibilità numerica o per supportare
il "core".
Ai diversi tipi di lavoratori
corrispondono anche diverse metodologie formative e di arricchimento delle
conoscenze professionali: per i lavoratori centrali la formazione fa parte
dell'attività lavorativa, per quelli periferici vige l' on job training, tipicamente svolto nell'azienda a spese della collettività;
il gruppo esterno, infine, non ha alcun supporto formativo, anche se in alcuni
casi la loro possibilità di lavoro è legata all'altissimo livello di know-how
posseduto ().
Il modello appena illustrato,
tra i vari pregi, possiede quello dell'adattabilità alle diverse situazioni
aziendali e nazionali. Inoltre, sembra
essere una delle rappresentazioni più aderenti alla struttura di alcune moderne
aziende terziarie, specialmente di quelle di piccola-media grandezza dedicate
ai servizi alla produzione e di rete.
3. LA FLESSIBILITA’ DEI MERCATI DEL LAVORO IN EUROPA
Il mercato del lavoro nelle diverse
nazioni europee è o meno contraddistinto da un’elevata flessibilità? La domanda,
tutt’altro che retorica, avrà, a seconda degli interlocutori, risposte ben
diverse. I datori di lavoro, in qualsiasi nazione essi operino, diranno, prendendo
a paragone gli Stati Uniti d’America, che il mercato europeo è scarsamente
flessibile, imbrigliato in “lacci e lacciuoli” che rendono difficile alle
aziende adattare il proprio assetto all’andamento della domanda. Inoltre porteranno
a sostegno della loro tesi le molte leggi che tutte le nazioni hanno sviluppato
per garantire un adeguato livello di protezione della manodopera contro i
licenziamenti (Statuti di vario genere, ammortizzatori sociali, ecc.). I rappresentanti
dei sindacati, viceversa, affermeranno che la de-regulation che ha caratterizzato le
politiche pubbliche nel corso degli anni Ottanta ha portato ad un “imbarbarimento”
del mercato del lavoro, ove figure sempre meno garantite in senso classico
(lavoratori a termine, giovani con salari “d’ingresso”, telelavoratori, ecc.)
sono andati a sostituire ampie fette di occupazione stabile. Ambedue, seppur
entro alcuni limiti, hanno una parte di ragione: nell’ambito dell’Unione europea
i due fenomeni coesistono. Da una parte vi è stata una indubbia flessibilizzazione
dell’occupazione per far fronte, almeno in parte, alle pressanti richieste
datoriali; dall’altra la tenuta di una tradizione di gestione
sociale del mercato del lavoro, che garantisce ai dipendenti una serie
di garanzie delle quali si potrebbe fare a meno soltanto in prossimità di
una situazione di “quasi-piena occupazione” (M. Emerson, 1991).
Attraversando l’Ue, però, le situazioni
nazionali che si incontrano sono assai differenziate. Alcuni paesi (come il
Regno Unito, ad esempio) espongono alti livelli di flessibilità nell’uso della
manodopera; altri (come l’Italia e le nazioni mediterranee in genere) in cui
prevalgono le rigidità. Ma come vengono costruiti, tipicamente, i vari indici
descrittivi della rigidità/flessibilità del mercato del lavoro? La gran parte
degli studi parte, invariabilmente, dalla quota di lavoratori a tempo parziale
presenti nelle diverse nazioni. Essendo questa la modalità di lavoro atipico
più diffusa (nonchè quella per la quale si dispone delle maggiori informazioni
statistiche cross-national), è giocoforza
adottarlo come lo stimatore di maggior importanza per analizzare il fenomeno.
Una breve osservazione condotta su tale variabile (vedere tabelle 4
e 5) ci fornisce un primo quadro sulla flessibilità. In Europa, nel 1991,
il lavoro a tempo parziale interessava oltre 13,5 milioni di lavoratori, per
la grandissima maggioranza (oltre l’80%) donne.
Il part-time, quasi ovunque, coinvolge tra il 2 e il 4% della manodopera
maschile e oltre il 20% di quella femminile. Fanno eccezione Italia, Spagna,
Portogallo e Grecia, ove le occupazioni a tempo parziale sono pochissimo sviluppate
e, su un altro versante, Danimarca, Olanda e (seppur in misura ridotta) la
Gran Bretagna, nelle quali il part-time interessa in maniera consistente anche gli uomini.
Tabella 4:
Il lavoro part-time in Europa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valori assoluti e percentuali
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Belgio
|
Danimarca
|
Germania
|
Grecia
|
Spagna
|
Francia
|
Irlanda
|
Italia
|
Lussemburgo
|
Olanda
|
Portogallo
|
Regno Unito
|
EUR 12
|
|
|
v.a.
|
%
|
v.a.
|
%
|
v.a.
|
%
|
v.a.
|
%
|
v.a.
|
%
|
v.a.
|
%
|
v.a.
|
%
|
v.a.
|
%
|
v.a.
|
%
|
v.a.
|
%
|
v.a.
|
%
|
v.a.
|
%
|
v.a.
|
%
|
|
Maschi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1985
|
33
|
1,8
|
105
|
8,9
|
192
|
1,4
|
32
|
2,6
|
*
|
*
|
280
|
2,8
|
11
|
2,1
|
234
|
2,4
|
2
|
2,5
|
226
|
7,7
|
*
|
*
|
479
|
4,0
|
*
|
*
|
|
1986
|
38
|
2,1
|
114
|
9,2
|
206
|
1,5
|
31
|
2,6
|
*
|
*
|
325
|
3,2
|
14
|
2,8
|
217
|
2,2
|
2
|
1,9
|
190
|
6,1
|
24
|
1,3
|
521
|
4,4
|
*
|
*
|
|
1987
|
38
|
2,1
|
120
|
9,8
|
191
|
1,3
|
25
|
2,1
|
91
|
1,6
|
329
|
3,3
|
16
|
3,1
|
243
|
2,6
|
*
|
*
|
436
|
13,2
|
28
|
1,5
|
594
|
5,0
|
2111
|
3,4
|
|
1988
|
38
|
2,1
|
117
|
9,3
|
217
|
1,5
|
28
|
2,3
|
78
|
1,3
|
319
|
3,2
|
19
|
3,8
|
262
|
2,7
|
2
|
1,9
|
465
|
14,2
|
30
|
1,6
|
653
|
5,3
|
2228
|
3,6
|
|
1989
|
33
|
1,8
|
122
|
9,9
|
253
|
1,7
|
27
|
2,1
|
63
|
1,0
|
345
|
3,3
|
17
|
3,4
|
234
|
2,5
|
2
|
1,8
|
495
|
14,8
|
18
|
0,9
|
556
|
4,6
|
2165
|
3,4
|
|
1990
|
40
|
2,2
|
132
|
10,8
|
317
|
2,1
|
24
|
1,9
|
65
|
1,0
|
320
|
3,1
|
18
|
3,6
|
208
|
2,1
|
2
|
1,8
|
506
|
14,7
|
29
|
1,5
|
604
|
5,0
|
2265
|
3,5
|
|
1991
|
40
|
2,2
|
133
|
10,9
|
338
|
2,2
|
21
|
1,7
|
69
|
1,1
|
335
|
3,2
|
19
|
3,7
|
239
|
2,5
|
*
|
*
|
542
|
15,5
|
31
|
1,6
|
638
|
5,4
|
2405
|
3,8
|
|
Femmine
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1985
|
227
|
23,2
|
460
|
44,2
|
2632
|
29,1
|
46
|
8,3
|
*
|
*
|
1579
|
21,0
|
36
|
12,7
|
421
|
8,6
|
7
|
16,1
|
791
|
51,0
|
*
|
*
|
4133
|
44,5
|
*
|
*
|
|
1986
|
255
|
25,2
|
468
|
42,7
|
2675
|
29,2
|
44
|
7,8
|
*
|
*
|
1737
|
22,5
|
37
|
12,4
|
286
|
7,7
|
7
|
16,5
|
804
|
49,8
|
90
|
8,1
|
4236
|
44,8
|
*
|
*
|
|
1987
|
274
|
26,6
|
472
|
42,8
|
2676
|
29,0
|
46
|
8,0
|
289
|
12,8
|
1736
|
22,5
|
44
|
14,0
|
441
|
8,7
|
9
|
18,1
|
1006
|
56,0
|
100
|
8,7
|
4625
|
44,5
|
11718
|
28,6
|
|
1988
|
277
|
26,1
|
477
|
42,1
|
2822
|
30,0
|
46
|
7,4
|
310
|
12,5
|
1839
|
23,5
|
48
|
15,3
|
485
|
9,3
|
7
|
15,2
|
1064
|
56,1
|
108
|
8,8
|
4431
|
44,0
|
11914
|
28,8
|
|
1989
|
305
|
28,0
|
452
|
40,6
|
2919
|
30,4
|
44
|
6,8
|
300
|
11,1
|
1886
|
23,6
|
49
|
15,3
|
531
|
10,0
|
8
|
16,4
|
1142
|
58,4
|
101
|
7,7
|
4530
|
43,5
|
12267
|
28,9
|
|
1990
|
330
|
29,3
|
443
|
39,1
|
3552
|
33,6
|
39
|
5,7
|
329
|
11,3
|
1914
|
23,6
|
55
|
16,4
|
509
|
9,2
|
8
|
16,6
|
1179
|
57,7
|
97
|
7,1
|
4545
|
43,1
|
13000
|
29,3
|
|
1991
|
368
|
30,5
|
433
|
28,3
|
3651
|
34,0
|
32
|
4,8
|
323
|
10,6
|
1968
|
23,6
|
59
|
17,2
|
552
|
9,7
|
9
|
18,4
|
1274
|
58,6
|
92
|
6,5
|
4569
|
43,7
|
13330
|
29,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Numeri indici
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Belgio
|
Danimarca
|
Germania
|
Grecia
|
Spagna
|
Francia
|
Irlanda
|
Italia
|
Lussemburgo
|
Olanda
|
Portogallo
|
Regno Unito
|
EUR 12
|
|
|
%
|
n.i.
|
%
|
n.i.
|
%
|
n.i.
|
%
|
n.i.
|
%
|
n.i.
|
%
|
n.i.
|
%
|
n.i.
|
%
|
n.i.
|
%
|
n.i.
|
%
|
n.i.
|
%
|
n.i.
|
%
|
n.i.
|
%
|
n.i.
|
|
Maschi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1985
|
1,8
|
|
8,9
|
|
1,4
|
|
2,6
|
|
|
|
2,8
|
|
2,1
|
|
2,4
|
|
2,5
|
|
7,7
|
|
|
|
4,0
|
|
|
|
|
1986
|
2,1
|
|
9,2
|
|
1,5
|
|
2,6
|
|
|
|
3,2
|
|
2,8
|
|
2,2
|
|
1,9
|
|
6,1
|
|
1,3
|
|
4,4
|
|
|
|
|
1987
|
2,1
|
62
|
9,8
|
288
|
1,3
|
38
|
2,1
|
62
|
1,6
|
47
|
3,3
|
97
|
3,1
|
91
|
2,6
|
76
|
|
0
|
13,2
|
388
|
1,5
|
44
|
5,0
|
147
|
3,4
|
100
|
|
1988
|
2,1
|
58
|
9,3
|
258
|
1,5
|
42
|
2,3
|
64
|
1,3
|
36
|
3,2
|
89
|
3,8
|
106
|
2,7
|
75
|
1,9
|
53
|
14,2
|
394
|
1,6
|
44
|
5,3
|
147
|
3,6
|
100
|
|
1989
|
1,8
|
53
|
9,9
|
291
|
1,7
|
50
|
2,1
|
62
|
1,0
|
29
|
3,3
|
97
|
3,4
|
100
|
2,5
|
74
|
1,8
|
53
|
14,8
|
435
|
0,9
|
26
|
4,6
|
135
|
3,4
|
100
|
|
1990
|
2,2
|
63
|
10,8
|
309
|
2,1
|
60
|
1,9
|
54
|
1,0
|
29
|
3,1
|
89
|
3,6
|
103
|
2,1
|
60
|
1,8
|
51
|
14,7
|
420
|
1,5
|
43
|
5,0
|
143
|
3,5
|
100
|
|
1991
|
2,2
|
58
|
10,9
|
287
|
2,2
|
58
|
1,7
|
45
|
1,1
|
29
|
3,2
|
84
|
3,7
|
97
|
2,5
|
66
|
|
0
|
15,5
|
408
|
1,6
|
42
|
5,4
|
142
|
3,8
|
100
|
|
Femmine
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1985
|
23,2
|
|
44,2
|
|
29,1
|
|
8,3
|
|
|
|
21,0
|
|
12,7
|
|
8,6
|
|
16,1
|
|
51,0
|
|
|
|
44,5
|
|
|
|
|
1986
|
25,2
|
|
42,7
|
|
29,2
|
|
7,8
|
|
|
|
22,5
|
|
12,4
|
|
7,7
|
|
16,5
|
|
49,8
|
|
8,1
|
|
44,8
|
|
|
|
|
1987
|
26,6
|
93
|
42,8
|
150
|
29,0
|
101
|
8,0
|
28
|
12,8
|
45
|
22,5
|
79
|
14,0
|
49
|
8,7
|
30
|
18,1
|
63
|
56,0
|
196
|
8,7
|
30
|
44,5
|
156
|
28,6
|
100
|
|
1988
|
26,1
|
91
|
42,1
|
146
|
30,0
|
104
|
7,4
|
26
|
12,5
|
43
|
23,5
|
82
|
15,3
|
53
|
9,3
|
32
|
15,2
|
53
|
56,1
|
195
|
8,8
|
31
|
44,0
|
153
|
28,8
|
100
|
|
1989
|
28,0
|
97
|
40,6
|
140
|
30,4
|
105
|
6,8
|
24
|
11,1
|
38
|
23,6
|
82
|
15,3
|
53
|
10,0
|
35
|
16,4
|
57
|
58,4
|
202
|
7,7
|
27
|
43,5
|
151
|
28,9
|
100
|
|
1990
|
29,3
|
100
|
39,1
|
133
|
33,6
|
115
|
5,7
|
19
|
11,3
|
39
|
23,6
|
81
|
16,4
|
56
|
9,2
|
31
|
16,6
|
57
|
57,7
|
197
|
7,1
|
24
|
43,1
|
147
|
29,3
|
100
|
|
1991
|
30,5
|
103
|
28,3
|
96
|
34,0
|
115
|
4,8
|
16
|
10,6
|
36
|
23,6
|
80
|
17,2
|
58
|
9,7
|
33
|
18,4
|
62
|
58,6
|
199
|
6,5
|
22
|
43,7
|
148
|
29,5
|
100
|
|
Tabella 5: Tasso di femminilizzazione del lavoro part-time
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Belgio
|
Danimarca
|
Germania
|
Grecia
|
Spagna
|
Francia
|
Irlanda
|
Italia
|
Lussemburgo
|
Olanda
|
Portogallo
|
Regno Unito
|
EUR 12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1985
|
87,3
|
81,4
|
93,2
|
59,0
|
|
84,9
|
76,6
|
64,3
|
77,8
|
77,8
|
|
89,6
|
|
|
1986
|
87,0
|
80,4
|
92,8
|
58,7
|
|
84,2
|
72,5
|
56,9
|
77,8
|
80,9
|
78,9
|
89,0
|
|
|
1987
|
87,8
|
79,7
|
93,3
|
64,8
|
76,1
|
84,1
|
73,3
|
64,5
|
|
69,8
|
78,1
|
88,6
|
84,7
|
|
1988
|
87,9
|
80,3
|
92,9
|
62,2
|
79,9
|
85,2
|
71,6
|
64,9
|
77,8
|
69,6
|
78,3
|
87,2
|
84,2
|
|
1989
|
90,2
|
78,7
|
92,0
|
62,0
|
82,6
|
84,5
|
74,2
|
69,4
|
80,0
|
69,8
|
84,9
|
89,1
|
85,0
|
|
1990
|
89,2
|
77,0
|
91,8
|
61,9
|
83,5
|
85,7
|
75,3
|
71,0
|
80,0
|
70,0
|
77,0
|
88,3
|
85,2
|
|
1991
|
90,2
|
76,5
|
91,5
|
60,4
|
82,4
|
85,5
|
75,6
|
69,8
|
|
70,2
|
74,8
|
87,7
|
84,7
|
Si profila, quindi, una configurazione
“a più fasce”: da una parte le nazioni dell’area mediterranea, contraddistinte
da un mercato del lavoro rigido; dall’altra i Paesi più a nord, “campioni”
della flessibilità. Tra questi due estremi vi sono le restanti nazioni del
centro Europa. E’ evidente che, nella diffusione del lavoro part-time (e soprattutto
nelle differenze riscontrate tra i diversi paesi) vi sono più spiegazioni:
legislative, sociali, culturali. Queste ultime sembrano avere una importanza
particolare. Dederichs e Kohler (1993) in uno studio per la Fondazione europea
sul part-time attribuiscono alla femminilizzazione del mercato del lavoro
le differenze nazionali:
“Sostanzialmente, nei paesi ad
alta incidenza dell’occupazione femminile anche la quota dei dipendenti a
tempo parziale è elevata. (...) Inversamente,
la quota dei dipendenti a tempo parziale in paesi quali Irlanda, Italia e
Spagna è relativamente modesta in quanto in tali paesi anche l’incidenza dell’occupazione
femminile è relativamente scarsa” (pag. 56)
Si tratta, non vi è dubbio, di
un buon punto di partenza per l’analisi. Ed anche cruciale, in quanto abbiamo
assunto la quota di part-time come indicatore della flessibilità del mercato
del lavoro. Spiegare quindi i differenziali intra-nazionali dell’una variabile
permette di comprendere anche l’altra. Per confermare (o invalidare) gli assunti
dello studio della Fondazione europea abbiamo condotto, partendo dai dati
statistici dell’Eurostat, una serie di regressioni lineari, incrociando, per
i diversi paesi e per alcuni anni, il tasso di femminilizzazione del mercato
del lavoro con la quota di occupati a tempo parziale. I risultati ottenuti,
riportati sotto forma grafica in figura 4, mostrano, effettivamente, l’esistenza
di una relazione diretta tra le due grandezze. I dodici paesi dell’Ue, infatti,
si distribuiscono secondo tre clusters principali: paesi ad alta femminilizzazione del mercato del
lavoro e alto livello di part-time (Regno Unito e Danimarca), paesi con valori
medi per ambedue le modalità (Belgio, Irlanda, Germania e Francia), nazioni
con bassi indici per entrambe le variabili. Vi sono, però, anche alcune eccezioni
di discreta importanza: l’Olanda, che come abbiamo visto ha la più alta concentrazione
di lavori a tempo parziale, espone invece una quota di occupazione femminile
medio-bassa; il Portogallo, che pur avendo un tasso di femminilizzazione superiore
a quello tedesco (42,2% nel 1991) è in penultima posizione per il numero di
occupati part-time; la Francia che, con il 44% di donne inserite nel mondo
del lavoro, ha “soltanto” il 12% di forza lavoro a tempo parziale.
Le incongruenze appena citate
hanno, come logico, un riflesso immediato sulla capacità esplicativa del modello
posto a base della regressione lineare. Il coefficiente r quadro (che misura
la quota di varianza spiegata dalla variabile “femminilizzazione del mercato
del lavoro”), seppur significativo sino al 1990, è tutto sommato basso e in
diminuzione nel periodo preso in esame (tabella 6). Ciò suggerisce, quindi, di prendere in considerazione
anche altre spiegazioni.
Figura 4
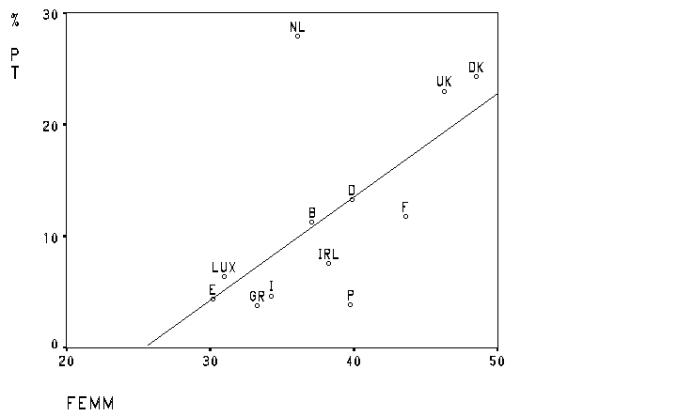
Tabella 6. Regressione tra quota di
occupazione part-time e femminilizzazione del mercato del lavoro.
|
Anno
|
Equazione della retta di regressione
|
r quadro
|
|
1985
|
%pt=-24,4+0,96*femm
|
0,40
|
|
1986
|
%pt=-16,7+0,75*femm
|
0,39
|
|
1987
|
%pt=-22,1+0,93*femm
|
0,35
|
|
1988
|
%pt=-24,1+0,95*femm
|
0,36
|
|
1989
|
%pt=-24,9+0,96*femm
|
0,34
|
|
1990
|
%pt=-23,1+0,91*femm
|
0,31
|
|
1991
|
%pt=-16,2+0,71*femm
|
0,22
|
Fonte: nostra elaborazione su dati Eurostat.
Se guardiamo la struttura del
mercato del lavoro nei diversi paesi vediamo che esistono differenze notevoli
non soltanto nel grado di partecipazione della manodopera femminile ma, anche,
nella distribuzione intersettoriale dell’occupazione e nel rapporto esistente
tra lavoro indipendente e dipendente (tabella 7, 8 e 9). Differenze, per inciso,
che sembrano andare tutte nella stessa direzione: le regioni dell’Europa mediterranea
(le stesse contraddistinte da una ridotta quota di part-time) hanno quasi
sempre un’alta percentuale di lavoratori indipendenti e un ridotto sviluppo
del settore terziario (). Questo ci permette quindi di espandere
il modello utilizzato nella regressione inserendo le nuove variabili. In questa
maniera otteniamo un risultato decisamente migliore sotto il profilo statistico:
le tre variabili (femminilizzazione del mercato del lavoro, quota di occupazione
indipendente e percentuale di occupazione nel settore terziario) riescono
a spiegare una quota molto elevata (il 64,3%) () delle variazioni intra-nazionali
del part-time. Prese individualmente, poi, le variabili maggiormente correlate
con il part-time risultano essere la terziarizzazione dell’occupazione (all’aumentare
della manodopera impiegata nei servizi aumenta anche il lavoro part-time)
e la percentuale di lavoro indipendente (tanto più questo è sviluppato, tanto
meno si lavorerà a tempo parziale, come si vede dalla figura 5).
Figura 5
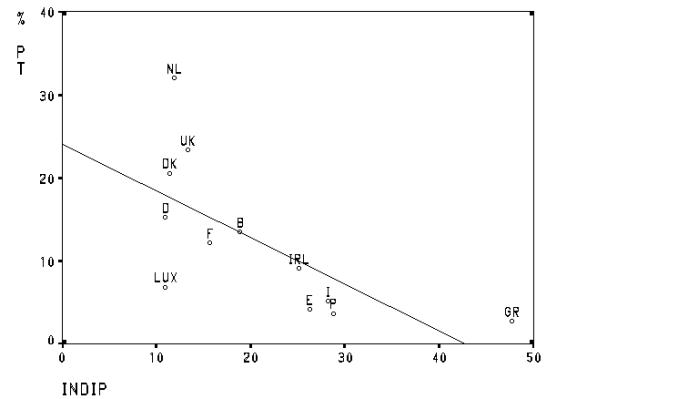
Tabella 7: Alcune condizioni strutturali
di sintesi del mercato del lavoro europeo nel 1992.
|
|
Quota di lavoratori Part-time
|
Femminiliz-zazione del mercato del lavoro
|
Quota di lavoratori indipendenti
|
Quota di occupazione nei servizi
|
Quota di occupazione in
agricoltura
|
|
Belgio
|
13,5
|
39,9
|
18,9
|
66,0
|
3,3
|
|
Danimarca
|
20,6
|
55,6
|
11,4
|
67,0
|
5,6
|
|
Germania
|
15,3
|
41,1
|
11,0
|
56,2
|
3,7
|
|
Grecia
|
2,8
|
35,1
|
47,7
|
50,2
|
23,9
|
|
Spagna
|
4,2
|
32,7
|
26,3
|
54,6
|
11,9
|
|
Francia
|
12,2
|
44,3
|
15,7
|
63,2
|
6,4
|
|
Irlanda
|
9,1
|
40,0
|
25,1
|
55,9
|
15,3
|
|
Italia
|
5,2
|
37,3
|
28,2
|
58,6
|
9,0
|
|
Olanda
|
32,0
|
38,3
|
11,9
|
69,1
|
4,7
|
|
Portogallo
|
3,7
|
42,2
|
28,8
|
47,8
|
18,1
|
|
Regno Unito
|
23,4
|
46,9
|
13,4
|
65,5
|
2,2
|
|
Lussemburgo
|
6,9
|
30,3
|
11,0
|
66,9
|
3,7
|
|
Media europea
|
14,5
|
41,7
|
18,5
|
60,1
|
6,7
|
Fonte: nostra elaborazione su dati Eurostat
Tabella 8: Distribuzione settoriale
e per tipologia degli occupati nell’Unione Europea. (Totale maschi e femmine,
1992)
|
|
Media europea
|
Belgio
|
Dani-marca
|
Germa-nia
|
Grecia
|
Spagna
|
Francia
|
Irlanda
|
Italia
|
Lussem-burgo
|
Olanda
|
Porto-gallo
|
Regno Unito
|
|
Agricoltura
|
6,7
|
3,3
|
5,6
|
3,7
|
23,9
|
11,9
|
6,4
|
15,3
|
9,0
|
3,7
|
4,7
|
18,1
|
2,2
|
|
Industria
|
33,2
|
30,7
|
27,4
|
40,1
|
25,9
|
33,5
|
30,4
|
28,8
|
32,4
|
29,4
|
26,3
|
34,1
|
32,3
|
|
Servizi
|
60,1
|
66,0
|
67,0
|
56,2
|
50,2
|
54,6
|
63,2
|
55,9
|
58,6
|
66,9
|
69,1
|
47,8
|
65,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lavoratori
indipendenti
|
15,7
|
16,1
|
9,5
|
8,9
|
34,8
|
20,9
|
12,9
|
22,6
|
24,3
|
9,3
|
10,0
|
25,8
|
13,4
|
|
Lavoratori
dipendenti
|
81,5
|
81,1
|
88,6
|
89,0
|
52,3
|
73,7
|
84,3
|
74,9
|
71,8
|
89,0
|
88,1
|
71,2
|
86,6
|
|
Collaboratori
familiari
|
2,8
|
2,9
|
1,9
|
2,0
|
12,9
|
5,4
|
2,8
|
2,5
|
4,0
|
1,7
|
2,0
|
3,0
|
0,0
|
Fonte: nostra elaborazione su dati Eurostat
Tabella 9: Percentuale di lavoratori indipendenti per settore di attività
nell’Unione Europea. (Totale maschi e femmine, 1992)
|
|
Media europea
|
Belgio
|
Dani-marca
|
Germa-nia
|
Grecia
|
Spagna
|
Francia
|
Irlanda
|
Italia
|
Lussem-burgo
|
Olanda
|
Porto-gallo
|
Regno Unito
|
|
Agricoltura
|
72,0
|
87,9
|
64,7
|
73,0
|
96,1
|
68,6
|
81,9
|
86,3
|
57,2
|
8,2
|
62,2
|
80,3
|
53,6
|
|
Industria
|
11,2
|
9,4
|
8,5
|
5,0
|
28,7
|
14,2
|
10,2
|
11,0
|
16,9
|
4,5
|
4,8
|
12,5
|
13,9
|
|
Servizi
|
16,5
|
19,9
|
8,2
|
11,1
|
34,4
|
24,5
|
11,6
|
15,7
|
30,1
|
9,4
|
11,2
|
21,0
|
11,8
|
Fonte: nostra elaborazione su
dati Eurostat
In conclusione, uscendo dal linguaggio
dei numeri, ci sembra possibile fornire una spiegazione convincente (e in parte diversa da quella assunta
da Dederichs e Kohler [1993] ) dei meccanismi che favoriscono o meno la creazione
di impieghi a tempo parziale e, di conseguenza, che creano un’immagine di maggiore/minore flessibilità
del mercato del lavoro di una nazione. La flessibilità, infatti, non dipende
se non in piccola parte dalla possibilità di avere manodopera disponibile
per i lavori atipici (come è il caso dei giovani e delle donne che scelgono
o subiscono il part-time); di fondamentale importanza è la morfologia dello
stesso mercato del lavoro, il suo grado
di modernità. Ove è possibile lavorare in maniera auto-diretta (ampia
esistenza di lavoro autonomo) e laddove esiste un tessuto di imprese (magari
piccole aziende agricole o imprese del terziario tradizionale costruite intorno
ad una famiglia allargata), la scelta di flessibilità di molti lavoratori
consiste nello sfruttamento di tali possibilità. Non vi è, oggettivamente, la necessità di ricorrere al mercato “esterno”
cercando di adattarsi alle sue esigenze. Così le aziende vengono private di una consistente quota di forza
lavoro flessibile “diretta” e si vedono costrette a fare ampio ricorso al
sub-appalto e al lavoro su commessa. Questo,
naturalmente, non contraddice la visione “classica”, secondo cui le Nazioni
con basse percentuali di part-time hanno anche mercati del lavoro assai rigidi,
ma ne circoscrive i contorni: in molti casi nazionali la flessibilità della
prestazione lavorativa è ottenuta per altre strade: lavoro autonomo, micro-imprenditorialità,
sfruttamento delle aziende operanti nei settori economici a basso valore aggiunto.
Le diverse strategie, naturalmente, sono determinate dalle legislazioni nazionali e dallo stato delle
relazioni industriali. Laddove è difficile per le aziende ottenere dai propri
dipendenti condizioni di lavoro flessibili, si è giocoforza costretti ad usare il “polmone” del lavoro indipendente,
spesse volte poco più che una forma di lavoro dipendente mascherato, come
nel caso dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
4. IL CASO ITALIANO
L’Italia sembra inserita a pieno
titolo nel processo di modernizzazione dei mercati del lavoro appena delineato.
Partendo da una normativa che assegnava centralità al contratto di
lavoro a tempo pieno di durata illimitata, si è passati, tramite una serie
consistente di eccezioni, ad una de-regolamentazione “assistita”. Ma anche
incompleta, in quanto lascia eccessiva discrezionalità alle parti sociali
(e ai rapporti di forza tra queste) nel determinare le condizioni e l’estensione
del ricorso a forme di lavoro atipiche. E’ nei contratti collettivi, infatti,
che viene fissata la percentuale massima di occupati che, in un’azienda, possono
avere un contratto a tempo parziale o temporaneo. Tipicamente la soglia fissata
è oscillante tra il 10 e il 15% degli occupati (Treu, 1993) ma, come visto,
a livello nazionale il ricorso al part-time supera di pochissimo il 5%. Un’accelerazione
delle forme di lavoro atipiche si è avuta a partire dalla metà degli anni
Ottanta, allorquando fu prevista (Legge 863/84) la possibilità di stipulare
sia particolari contratti a tempo parziale (detti di solidarietà) per evitare
il ricorso ai licenziamenti sia a termine (per un massimo di due anni non
rinnovabili), per l'inserimento di giovani in fase di training (Contratti
di Formazione e Lavoro). Questo, come
si vede nelle tabelle 10 e 11 che seguono, ha permesso, almeno nella fase
iniziale, uno sviluppo molto rapido, specialmente nel terziario, di entrambe
le forme di lavoro atipico. Ciònonostante, nel caso italiano non sono stati
questi gli strumenti principali adottati dalle aziende per giungere ad una
maggiore flessibilità. Uno studio recente e ben documentato svolto sul nostro
paese da due ricercatori del BIT di Ginevra, infatti, afferma che:
“la via prescelta dalle aziende
italiane per introdurre la flessibilità del lavoro sembra essere stata quella
degli accordi per orari di lavoro particolari. Negli anni ottanta gran parte
degli accordi collettivi nazionali di categoria hanno previsto un leggero
accorciamento dell’orario canonico di 40 ore per cinque giorni alla settimana,
stabilito negli anni settanta. Ma ancor più rilevante è il fatto che questi
accordi hanno introdotto un ventaglio di possibilità: lavoro a turni (compreso
il lavoro notturno per le donne in determinate circostanze); indennità per
attività disagiate, turni e lavori pesanti; redistribuzione delle ore e del
tempo di lavoro nell’ambito della giornata o su diverse settimane; riduzione
dell’orario (e del salario) e così via.” (Bruni & De Luca, 1994: pag.
172).
Si è assistito, insomma, ad una
richiesta di flessibilità intesa più a modificare le condizioni dei lavoratori
facenti parte del core group che
non ad un ricorso ad assunzioni “flessibili”.
Questo, se da una parte è dovuto alla particolare fase economica che
l’Italia (e l’Europa) ha attraversato, dall’altra è determinata dall’ampia
gamma di alternative di cui le aziende dispongono quando si rivolgono al mercato
del lavoro esterno.
|
Tabella 10: Avviati con contratti
a tempo parziale in Italia
|
|
|
ex art. 5 legge 863/84
|
|
|
Base 1987=100
|
|
|
Sesso
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uomini
|
Donne
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anni
|
v.a.
|
n.i.
|
v.a.
|
n.i.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1987
|
36.193
|
100
|
106.499
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1988
|
42.361
|
117
|
119.086
|
112
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1989
|
45.898
|
127
|
134.222
|
126
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1990
|
45.647
|
126
|
139.139
|
131
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1991
|
60.628
|
168
|
151.042
|
142
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1992
|
70.583
|
195
|
164.257
|
154
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1993
|
151.234
|
418
|
102.514
|
96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ampiezza dell'azienda (addetti)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1..49
|
50..249
|
250..499
|
>500
|
TOTALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anni
|
v.a.
|
n.i
|
v.a.
|
n.i
|
v.a.
|
n.i
|
v.a.
|
n.i
|
v.a.
|
n.i
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1987
|
103.865
|
100
|
23.540
|
100
|
9.342
|
100
|
5.945
|
100
|
142.692
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1988
|
115.761
|
111
|
25.054
|
106
|
11.160
|
119
|
9.472
|
159
|
161.447
|
113
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1989
|
129.424
|
125
|
27.976
|
119
|
12.974
|
139
|
9.746
|
164
|
180.120
|
126
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1990
|
136.077
|
131
|
28.533
|
121
|
10.721
|
115
|
9.455
|
159
|
184.786
|
129
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1991
|
152.905
|
147
|
35.106
|
149
|
13.049
|
140
|
10.610
|
178
|
211.670
|
148
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1992
|
166.746
|
161
|
41.382
|
176
|
15.165
|
162
|
11.547
|
194
|
234.840
|
165
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1993
|
183.460
|
177
|
42.122
|
179
|
14.210
|
152
|
13.956
|
235
|
253.748
|
178
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Settori NACE
|
|
|
|
Agricoltura
|
Industria
|
Servizi
|
|
|
Anni
|
Operai
|
Impiegati
|
Dipendenti
|
Operai
|
Impiegati
|
Dipendenti
|
Operai
|
Impiegati
|
Dipendenti
|
|
|
|
v.a.
|
n.i.
|
v.a.
|
n.i.
|
v.a.
|
n.i.
|
v.a.
|
n.i.
|
v.a.
|
n.i.
|
v.a.
|
n.i.
|
v.a.
|
n.i.
|
v.a.
|
n.i.
|
v.a.
|
n.i.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1987
|
32
|
100
|
141
|
100
|
173
|
100
|
23.655
|
100
|
15.268
|
100
|
38.923
|
100
|
61.072
|
100
|
42.524
|
100
|
103.596
|
100
|
|
|
1988
|
3
|
0 9
|
130
|
92
|
133
|
77
|
24.800
|
105
|
15.458
|
101
|
40.258
|
103
|
74.420
|
122
|
46.636
|
110
|
121.056
|
117
|
|
|
1989
|
5
|
16
|
122
|
87
|
127
|
73
|
26.082
|
110
|
15.991
|
105
|
42.073
|
108
|
82.725
|
135
|
55.195
|
130
|
137.920
|
133
|
|
|
1990
|
12
|
38
|
137
|
97
|
149
|
86
|
26.975
|
114
|
15.563
|
102
|
42.538
|
109
|
90.850
|
149
|
51.249
|
121
|
142.099
|
137
|
|
|
1991
|
1.981
|
6.191
|
1.168
|
828
|
3.149
|
1.820
|
31.222
|
132
|
19.670
|
129
|
50.892
|
131
|
97.081
|
159
|
60.548
|
142
|
157.629
|
152
|
|
|
1992
|
2.800
|
8.750
|
1.008
|
715
|
3.808
|
2.201
|
35.386
|
150
|
20.103
|
132
|
55.489
|
143
|
108.471
|
178
|
67.072
|
158
|
175.543
|
169
|
|
|
1993
|
254
|
794
|
507
|
360
|
761
|
440
|
39.585
|
167
|
21.061
|
138
|
60.646
|
156
|
121.292
|
199
|
71.049
|
167
|
192.341
|
186
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonte: nostre elaborazioni su dati Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tabella 11: Numero dei lavoratori avviati con contratto
a T.P. e CFL secondo le ripartizioni geografiche.
|
|
Base 1987=100
|
|
|
NORD
|
CENTRO
|
SUD
|
ITALIA
|
|
Anni
|
T.P.
|
n.i.
|
CFL
|
n.i.
|
T.P.
|
n.i.
|
CFL
|
n.i.
|
T.P.
|
n.i.
|
CFL
|
n.i.
|
T.P.
|
n.i.
|
CFL
|
n.i.
|
|
1987
|
102.519
|
100
|
299.618
|
100
|
28.808
|
100
|
69.926
|
100
|
11.365
|
100
|
33.312
|
100
|
142.692
|
100
|
402.856
|
100
|
|
1988
|
114.371
|
112
|
353.718
|
118
|
32.519
|
113
|
95.452
|
137
|
14.557
|
128
|
44.473
|
134
|
161.447
|
113
|
493.643
|
123
|
|
1989
|
126.205
|
123
|
375.007
|
125
|
35.806
|
124
|
100.049
|
143
|
18.109
|
159
|
55.043
|
165
|
180.120
|
126
|
530.099
|
132
|
|
1990
|
123.906
|
121
|
313.167
|
105
|
40.606
|
141
|
87.569
|
125
|
20.274
|
178
|
68.314
|
205
|
184.786
|
129
|
469.050
|
116
|
|
1991
|
142.663
|
139
|
185.020
|
62
|
44.906
|
156
|
66.371
|
95
|
24.101
|
212
|
64.952
|
195
|
211.670
|
148
|
316.343
|
79
|
|
1992
|
156.761
|
153
|
143.109
|
48
|
47.439
|
165
|
56.768
|
81
|
30.640
|
270
|
55.838
|
168
|
234.840
|
165
|
255.715
|
63
|
|
1993*
|
167.223
|
163
|
103.760
|
35
|
52.325
|
182
|
41.521
|
59
|
34.200
|
301
|
44.036
|
132
|
253.748
|
178
|
189.317
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonte: nostre
elaborazioni su dati Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Legenda:
T.P.=tempo parziale; CFL=contratto formazione e lavoro
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1993*= dato
stimato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tabella 12: L’imprenditorialità
in Italia. (dati al 31.12.92)
|
Aree geografiche
|
Società di capitale
|
Società di persone
|
Aziende individuali
|
Altre forme
|
Totale
|
|
Nord Ovest
|
223.790
|
313.283
|
677.418
|
29.673
|
1.244.164
|
|
Nord est
|
104.389
|
226.271
|
506.755
|
22.032
|
859.447
|
|
Centro
|
182.266
|
220.164
|
503.088
|
39.236
|
944.754
|
|
Sud e Isole
|
115.696
|
218.427
|
850.650
|
66.271
|
1.251.044
|
|
ITALIA
|
626.696
|
978.145
|
2.537.911
|
157.212
|
4.299.409
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Iscrizioni nel 1993
|
43.926
|
66.495
|
172.098
|
6.172
|
288.691
|
|
Cessazioni nel 1993
|
16.606
|
60.520
|
281.898
|
6.337
|
365.361
|
|
Tasso di cessazione
|
2,7
|
6,2
|
11,1
|
4,0
|
8,5
|
|
Tasso di crescita
|
4,4
|
0,6
|
-4,3
|
-0,1
|
-1,8
|
Fonte: Cerved
In Italia, come abbiamo visto,
è estremamente vasta l’area del lavoro autonomo e della micro imprenditorialità,
come testimoniano i dati delle Camere di Commercio (tabella 12). Più dell’80%
delle oltre 4 milioni di aziende italiane sono riconducibili a persone fisiche, siano esse singole o in associazione.
Questo “serbatoio” costituisce, per le aziende maggiori, una fonte di flessibilità
che, spesso ignorata, tende ad avvicinare il mercato del lavoro italiano a
quello delle altre nazioni europee.
L’enorme
sviluppo in Italia dell'occupazione "in proprio" è dovuta a più
cause: l’ampio tessuto di piccole aziende, tradizionale in varie aree del
paese (Piore & Sabel, 1987); le opportunità
di iniziare attività commerciali e produttive (specialmente nel settore
dei servizi alle famiglie) pur disponendo di "budget" limitati o
addirittura inesistenti; la particolare struttura del sistema fiscale italiano,
che lasciando ai lavoratori indipendenti ampie possibilità di "erosione",
sia legali che non, rende particolarmente conveniente il lavoro in proprio.
Anche quando questo si configura come una seconda attività "in nero"
o, addirittura, come una seconda "professione" (Accornero, 1995)
Tutti
i settori produttivi, anche quelli classici, hanno fatto ampio ricorso a queste
forme esterne di flessibilità. Nell’industria, ad esempio, l'occupazione dipendente,
stabile o in leggera crescita durante gli anni settanta, è andata diminuendo
dopo il 1980, con una perdita superiore alle 128.000 unità per anno. Diminuzione
che è poi accelerata ulteriormente a partire dal 1990. I settori più colpiti
dalla riduzione occupazionale sono stati quello delle costruzioni (-170.000
posti di lavoro tra il 1980 ed il 1988), della produzione dei mezzi di trasporto,
passati da 446.500 addetti a 341.100, delle industrie elettriche (-108.000
unità) e di quelle del legno (ridottosi del 20%). L'occupazione indipendente,
al contrario, è aumentata, rispetto al 1970, di circa il 23,5%
pur registrando, a partire dal 1983, una fase di leggero calo.
Il settore che ha avuto il maggior incremento del lavoro indipendente
è quello delle costruzioni, passate dalle 316.000 unità censite nel 1970 alle
oltre 575.000 del 1993.
La
tendenza all'"autonomia nel lavoro" è confermata anche dalle rilevazioni
trimestrali delle forze di lavoro. L’Istat, come noto, rinnova il campione
sottoposto ad indagine in modo ciclico; avviene quindi che una parte dei soggetti
vengano intervistati, nello stesso trimestre, in due anni successivi. Questo
permette di individuare i cambiamenti lavorativi eventualmente intervenuti
nell'anno. E, quindi, la mobilità intersettoriale della forza lavoro italiana.
Analizzando le risposte relative al 1988 () vediamo che soltanto il 60,3% di
coloro che l'anno prima si dichiaravano dipendenti agricoli continua a svolgere
la stessa attività. Il 6,42% di essi si è messo “in proprio”, pur
rimanendo nel settore, mentre il 5,1% ha ora un lavoro indipendente nell'industria
(tipicamente nell'edilizia); al terziario è passato il 7,5% del campione,
principalmente in attività dipendenti. Alta è anche la quota dei disoccupati, sia di quelli palesi (3,6%)
che, presumibilmente, degli occulti (più del 16% delle donne, ad un anno di
distanza, dichiara di non svolgere più altre attività che non quelle inerenti
la cura della casa). Maggiore è la
stabilità degli agricoltori indipendenti, che nel 71,5% dei casi continuano
a svolgere lo stesso lavoro. Chi cambia si sposta ai servizi (2,3% indipendenti,
1,2% come dipendenti) o, pur restando in agricoltura, diventano braccianti
(sono il 4,2%). Altissima è poi la
percentuale di coloro che si ritirano dal lavoro: ben l'8,5% degli indipendenti
(la media dei ritiri negli altri settori è intorno al 2%) ed il 4,7% dei dipendenti.
I
dipendenti industriali sono invece quelli che, dopo gli impiegati della Pubblica
Amministrazione (praticamente immobili nel lavoro) mostrano la maggiore stabilità
occupazionale: nel 77,8% dei casi continuano nell'impiego precedente. Quando
cambiano, lo fanno per divenire dipendenti di una azienda commerciale o per
entrare nello Stato. Scarsissimo (grazie anche all’ampio ricorso ad ammortizzatori
sociali quali la CIG) il tasso di disoccupazione palese (0,8%) od occulta.
E' invece discreta la mobilità verso un lavoro indipendente: 2,6% .
Comportamento assai meno stabile è individuabile tra i lavoratori indipendenti
dell'industria, che fuggono verso il terziario. In totale lo spostamento interessa
l'11,4% dei soggetti, di cui il 9% circa in attività indipendenti. Il settore del commercio è, invece, stabile.
Quasi il 79% degli operatori rimane nel proprio campo di attività; i dipendenti
si muovono verso il pubblico impiego nel 5,2% dei casi, verso il credito (5,6%)
e, soprattutto, verso l'industria (9,8%).
5. FLESSIBILI E INTERINALI
Seppure
in Europa il lavoro a tempo parziale e di durata determinata costituiscano
la fonte primaria di flessibilità del lavoro dipendente, esistono altre forme
di prestazione atipica, la più importante delle quali è rappresentata dal
cosiddetto lavoro interinale. Si tratta
di una prestazione contraddistinta dall’assenza del rapporto di dipendenza
con l’azienda in cui si opera, sostituita dalla subordinazione nei confronti
di un’impresa di lavoro temporaneo (tipicamente un’agenzia) che stipula un
contratto con la manodopera, la retribuisce e quindi la “affitta” per brevi
periodi ().
Ci troviamo di fronte, in sintesi, alla negazione del rapporto di lavoro dipendente
classico, ma assai lontani anche dalla prestazione autonoma. Nonostante l’importanza
attribuita sia a livello nazionale che comunitario al lavoro interinale (), va detto che esso costituisce,
ovunque, una esigua frazione dell’occupazione complessiva (tabella 13).
Secondo le stime delle stesse agenzie,
infatti, i lavoratori mobilitati giornalmente in tutto il mondo sono
soltanto tre milioni (il 50% dei quali nei soli Stati Uniti). Si calcola,
inoltre, che ogni candidato che stipula un rapporto con un’agenzia riesca
a lavorare (sempre in media) circa 20 giorni in un anno. Ciònonostante l'esistenza
o meno del lavoro interinale può modificare radicalmente le culture dei soggetti
che "ruotano" attorno al mercato del lavoro.
Tabella
13: Stime sul lavoro interinale nel mondo
(situazione
al maggio 1994)
|
|
|
|
|
|
|
PAESE
|
Totale
agenzie interinali
|
Media giornaliera
lavoratori temporanei (x 1.000)
|
n° di filiali
o affiliate
|
Fatturato (miliardi
di $)
|
|
|
|
|
|
|
|
Argentina
|
160
|
35
|
*
|
*
|
|
Australia
|
*
|
20
|
**550
|
*
|
|
Austria
|
400
|
8
|
**50
|
0,3
|
|
Belgio
|
93
|
30
|
531
|
1,2
|
|
Brasile
|
*
|
129
|
*
|
*
|
|
Canada
|
*
|
50
|
*
|
*
|
|
Antille Oland.
|
9
|
2
|
9
|
0,02
|
|
Danimarca
|
90
|
*
|
60
|
0,06
|
|
Francia
|
1100
|
300
|
5011
|
8,0
|
|
Germania
|
1800
|
100
|
2400
|
2,4
|
|
Irlanda
|
*
|
*
|
*
|
*
|
|
Giappone
|
*
|
**255
|
10250
|
10,0
|
|
Paesi Bassi
|
308
|
112
|
2125
|
2,5
|
|
Norvegia
|
65
|
4
|
102
|
0,13
|
|
Portogallo
|
*
|
3
|
300
|
*
|
|
Spagna
|
250
|
15
|
310
|
0,2
|
|
Sud Africa
|
*
|
25
|
*
|
*
|
|
Svezia
|
*
|
*
|
*
|
*
|
|
Svizzera
|
400
|
10
|
600
|
0,45
|
|
Regno Unito
|
4000
|
500
|
9000
|
11,0
|
|
USA
|
5500
|
1635
|
15000
|
30,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LEGENDA:
|
|
|
|
|
|
* statistiche non reperibili
|
|
|
|
|
** solo associate nazionali
|
|
|
|
|
Fonte: Associazione internazionale
delle Agenzie di lavoro temporaneo
|
In
Europa le modalità con le quali si svolge il rapporto interinale e, soprattutto,
le legislazioni nazionali in materia sono estremamente differenziate. Seguendo l’impostazione di uno
studioso autorevole come R. Blanpain (1993) possiamo dire che nel continente
coesistono tre situazioni principali: regolamentazione,
non regolamentazione, divieto. (figura 6).
Figura 6 : Tipi di legislazione sul lavoro interinale nell'Unione
Europea.
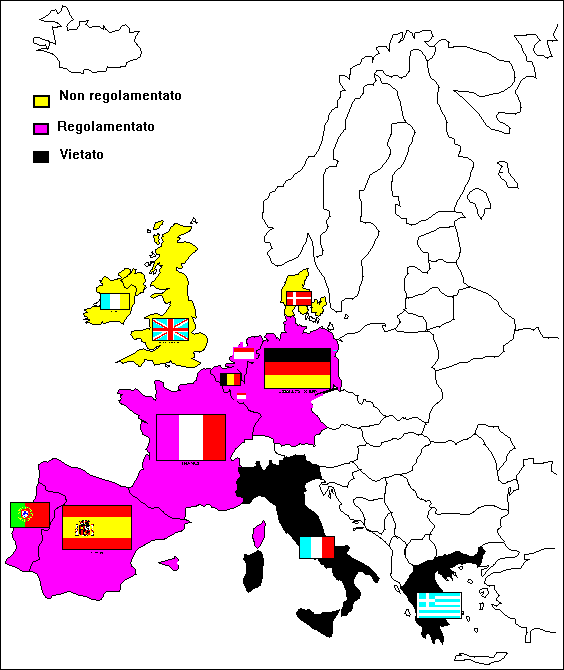
Soltanto
in Italia e Grecia, nonostante il dissenso espresso dal parlamento europeo,
il ricorso al lavoro interinale continua ad essere vietato. Ciò avviene a
causa dell’esistenza di un monopolio pubblico del collocamento, con conseguente
divieto di intermediazione privata di manodopera. Ciò non significa, naturalmente,
che negli anni più recenti non siamo apparsi in questi paesi proposte per
legalizzare il lavoro interinale nè, soprattutto, che non si sia sviluppato,
a seguito di deroghe legislative o nelle pieghe delle normative, un mercato
del lavoro “quasi interinale” (si pensi, in Italia, al sub-appalto di lavoro
di alta specializzazione, all’out-placement
di manodopera eccedente e alle prestazioni a terzi rese dai soci e dipendenti
di cooperative di servizi). Viceversa,
i paesi alle frontiere settentrionali dell’Europa (Danimarca, Irlanda e Regno
Unito) permettono il lavoro interinale senza regolamentarlo espressamente.
I soggetti interessati (agenzie, utenti e prestatori d’opera) si muovono nell’ambito della legislazione generale esistente,
che può essere garantista per il lavoratore (caso della Danimarca) o iper-liberista
verso le politiche aziendali (caso della Gran Bretagna, ove il contratto temporaneo
è considerato sui generis e soffre
quindi la riduzione delle normali tutele legali [Hepple, 1993]).
In posizione intermedia si vengono a trovare tutte le altre nazioni,
che dispongono di un corpo di normative, nate generalmente agli inizi degli
anni settanta (),
specificamente dedicate al lavoro temporaneo e interinale. Tra questi emergono
due indirizzi legislativi di un certo spessore, tanto che si può arrivare
a parlare addirittura di modelli differenti: quello tedesco, in cui il lavoratore
interinale viene assunto stabilmente dall’agenzia; quello francese, in cui
il prestatore d’opera stipula con l’agenzia un contratto per la sola durata
della “missione”. Si tratta di due
approcci entrambi con lati positivi e negativi, che trovano la loro giustificazione
principale nei diversi assetti del mercato del lavoro, nelle tradizioni lavorative
nazionali e nel sistema di relazioni industriali in atto.
6. CENNI CONCLUSIVI
Dalla breve analisi condotta sinora
risulta evidente come sia estremamente difficile anche soltanto ipotizzare
l'esistenza di alcune aziende (specialmente di servizi) senza i lavori atipici.
Dal punto di vista imprenditoriale, infatti, la rapidità di reazione e la
flessibilità verso le richieste del mercato divengono le variabili centrali
del processo produttivo e possono segnare il declino o, viceversa, il successo
aziendale. I lavori atipici (part-time, tempo determinato e prestazioni interinali)
sono congeniali a tale logica. E ciò sia che si sviluppino come modificazioni
dell’assetto nel gruppo centrale della manodopera aziendale, sia che essi
provengano dal mercato del lavoro esterno all’azienda.
Ciò, naturalmente, non implica, di per sè, un processo di "imbarbarimento"
in corso nel mondo del lavoro. Sarebbe errato associare meccanicamente valenze
negative ai contratti a termine, al part-time e a altre forme non standard
di prestazione. Secondo varie rilevanze
empiriche, infatti, gli impieghi atipici
(nelle particolari accezioni sviluppate nei diversi paesi) sembrano soddisfare
precise esigenze di flessibilità che provengono anche dal versante del lavoro. () Ma non va neanche sottovalutato l’esistenza
di un reale problema di fondo. E cioè che il lavoro atipico, nato magari come
scelta individuale, possa divenire poi una "gabbia insormontabile",
dalla quale il lavoratore non riesca ad uscire al mutare delle proprie esigenze
personali. O, viceversa, che divenga una condizione imposta e duratura, unico
sbocco occupazionale per i soggetti deboli del mercato. Queste preoccupazioni, particolarmente sentite
dai sindacati europei, sono se possibile ancora più accentuate in Italia.
L’alto tasso di disoccupazione giovanile e l’elevata disponibilità al lavoro
di quelli che le rilevazioni statistiche definiscono “soggetti in condizioni
non professionali”, infatti, potrebbe risolversi non solo con la creazione
di un mercato del lavoro atipico, ma anche (e di qui le preoccupazioni e resistenze)
con la sostituzione massiccia di occupazione stabile con occupazione precaria.
R I F E R I M E N T I B I B L I O G R A F I C I
Accornero, A. (1995), Ancora il lavoro. Conversazione con Patrizio
Di Nicola, Ediesse, Roma.
Accornero, A (1994), Il mondo della produzione, Il Mulino, Bologna.
Atkinson J. (1986) "Employment Flexibility
in Internal and External Labour Markets", in R. Dahrendorf, E. Kohler,
F. Piotet (a cura di), New Forms of
Work and Activity, Dublino, European Foundation for the Improvement of
Living and Working Conditions.
Aznar G., (1994), Lavorare meno per lavorare tutti, Bollati
Boringhieri, Torino.
Bruni, M., De Luca, L., (1994),
Flessibilità e disoccupazione: il caso Italia,
Ediesse, Roma.
Cerved (1994), Movimprese. Variazioni annuali nell’anagrafe
delle imprese italiane, Roma.
Chiesi A.M. (1990), "Un quadro
di riferimento concettuale", in Democrazia
e diritto, n. 1.
Dederichs, E., Kohler, E., (1993),
Lavoro a tempo parziale nella Comunità
europea. Aspetti sociali ed economici, Fondazione Europea per il miglioramento
delle condizioni di vita e di lavoro, Dublino.
Department of Employment (1990), "Women in
the labour market", Employment
Gazette, n. 12.
Distributive Trade EDC (1988), Part time working in the distributive trades,
Londra.
Emerson, M., (1991), Quale modello per l’Europa?, Il Mulino,
Bologna.
Eurostat, (1987), EC employees survey 1985-86, Lussemburgo, EC Press.
Eurostat (1992), Indagine sulle forze di lavoro. Risultati 1990,
Lussemburgo, EC Press.
Gallino, L. (a cura di, 1985),
Il lavoro e il suo doppio, Bologna, Il
Mulino.
Hepple, B., (1993), “United Kingdom”, in Blapain,
R. (a cura di), Temporary Work and Labour
Law, Kluwer, Deventer e Boston.
Isfol (1990), Rapporto Isfol 1990, Milano, Angeli.
Istat, (1994a), Occupazione e redditi da lavoro dipendente.
Anni 1980-93, Collana d’informazione n. 20, Roma.
Istat, (1994b), Rilevazione delle forze di lavoro. Media 1992,
Collana d’informazione n. 23, Roma.
Luciano A. (a cura di, 1989),
Arti maggiori, Roma, NIS.
Nardone T.J. (1986), "Part-time workers: who
are they ?", Monthly Labour Review,
Vol. 109, n. 2
Pero L. (1990), "L'impresa
chiede nuovi orari", in Democrazia
e diritto, n. 1.
Piore M.J., Sabel C.F. (1987),
Le due vie dello sviluppo industriale. Produzione
di massa e produzione flessibile, Torino, Isedi.
Piotet F. (1988), The Changing Face of Work, Dublino, European Foundation for the Improvement
of Living and Working Conditions.
Treu, T., (1993), “Italy”, in Blanpain, R. (a
cura di), Temporary Work and Labour
Law, Kluwer, Deventer e Boston.
) L'importanza delle politiche del lavoro messe in atto dai governi sembra
essere una delle variabili fondamentali nello sviluppo delle occupazioni atipiche.
Una recente ricerca della Fondazione Europea di Dublino nota che, mentre
le misure di emergenza messe in atto per alleviare la disoccupazione giovanile
tendono a divenire stabili, esse gradualmente contribuiscono alla modifica
dell'immagine stessa dell'impiego, tramite la creazione di mansioni non standard
con vari gradi di precarietà. (F. Piotet, 1988). Tale analisi sembra pienamente
applicabilie alla realtà italiana. Infatti negli anni Ottanta una discreta
percentuale di assunzioni è avvenuta per periodi determinati e soltanto grazie
a leggi dello Stato. In particolare: i contratti di formazione lavoro (legge
863/84) hanno dato luogo, nel periodo 1984-89 a circa 1.800.000 assunzioni
della durata media di 15-18 mesi; la legge sull'apprendistato (n.25/55), aggiornata
tramite vari accordi, ha creato nello stesso periodo oltre 2.600.000 posti
di lavoro temporaneo; la legge 67/88 sui lavori socialmente utili ha generato,
nei primi 18 mesi, oltre 150.000 contratti di lavoro a termine (durata inferiore
a 12 mesi) e part-time (un massimo di 80 ore mensili). (Per ulteriori dettagli
si rimanda a: Isfol, 1990 e alle considerazioni sviluppate nei paragrafi successivi).
) I risultati cui facciamo riferimento provengono da un’ampia ricerca svolta
all’inizio degli anni novanta dalla Fondazione Europea di Dublino in undici
stati dell’Unione (Dederichs & Kohler, 1993).
) Va notato, per inciso, che differenziali retributivi di tal genere sono
accettati, stando ad una indagine condotta nel 1985-86 dalla Comunità Europea
nei dodici Paesi membri (Eurostat, 1987), con favore dal 56 % dei lavoratori
dipendenti. Ma, al contempo, con grandi variazioni dovuti al Paese di residenza,
al sesso (le donne sono meno favorevoli degli uomini) ed alla funzione svolta
nell'organizzazione.
) Si pensi, ad esempio, ai managers “in affitto”.
) Questo avviene, va detto, quasi sempre per l’anomala ampiezza in queste
aree dei lavori legati all’agricoltura.
) Da notare che l'"r quadro aggiustato" è pari a 0,52.
) L’Istat, avendo in più occasioni ristrutturato il campione adottato per
le rilevazioni trimestrali, da alcuni anni non fornisce più i dati di “flusso”
della manodopera.
) Questa la
procedura tedesca. In Francia le cose vanno in maniera differente, in quanto
il lavoratore stabilisce un rapporto di durata variabile ma generalmente breve
con l'agenzia, finalizzato allo svolgimento della "missione" presso
un'azienda.
) In Italia, ad esempio, sin dalla scorsa legislatura erano state presentate
tre diverse proposte di legge per la regolamentazione del lavoro interinale,
cui si è aggiunta, dopo l’accordo sulla politica dei redditi del luglio 1993,
una di iniziativa governativa. Anche Ministro del lavoro del governo Berlusconi,
Mastella, ha presentato una sua ricetta per il lavoro interinale e
lo stesso ha poi fatto il suo successore, T. Treu.
A livello del parlamento europeo il lavoro "in affitto" è
oggetto di direttive che risalgono all’aprile del 1984.
) Illuminante, in materia è l'ampissima documentazione
statistica esistente nei paesi anglosassoni.(Cfr. T.J. Nardone, 1986; Eurostat,
1987; Distributive Trade EDC, 1988; Department of Employment, 1990).